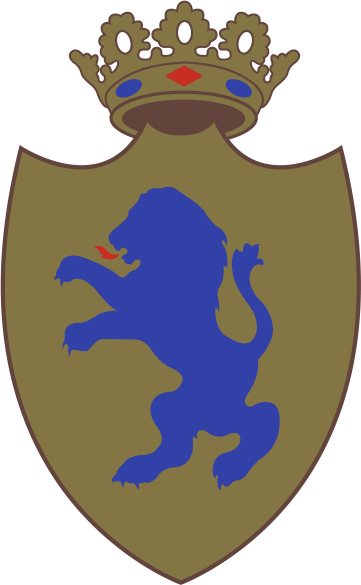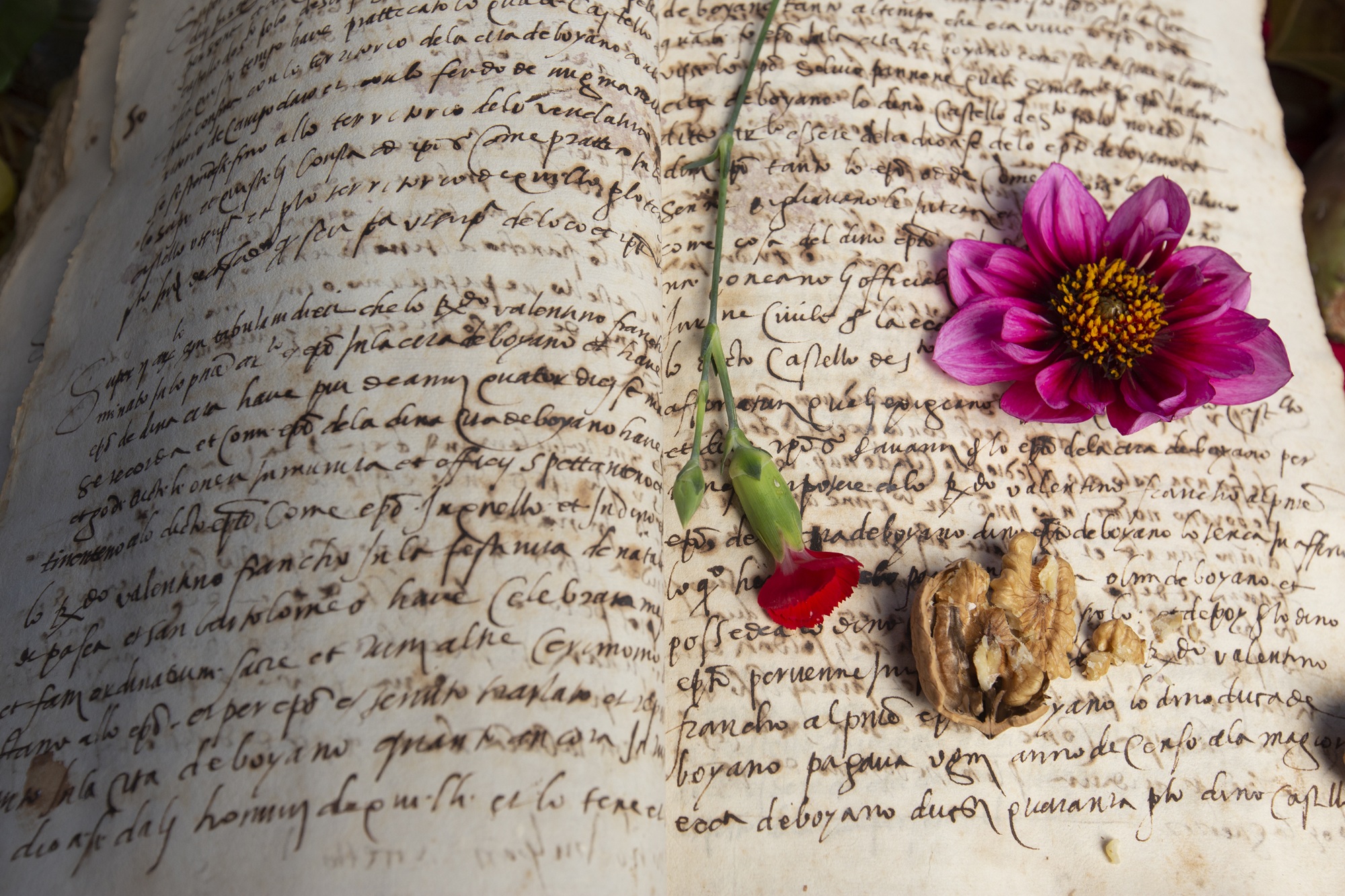LA STORIA
tra storia e leggenda
IIl toponimo “Marchione” deriva dall’alterazione linguistica di “Macchione”, attribuito al bosco esteso, fino all’Ottocento, per circa 1.320 ettari. Di esso sopravvivono alcuni straordinari esemplari di querce, che raggiungono anche i 500 anni. Ad esso era collegato il bosco che circondava la masseria detta di “San Pietro”, pure di proprietà dei conti di Conversano, venduta nel 1815, ma degli antichi alberi restano solo alcuni esemplari. Nel territorio di Conversano un altro straordinario luogo, pure di proprietà della Casa comitale, era destinato all’esercizio della caccia, il “Boschetto”, circondato da alte mura, con all’interno una grande vasca che serviva a far abbeverare i daini lì allevati per essere cacciati e per giri in barca.
La definizione dell’edificio come “castello di Marchione”, il più straordinario esempio di costruzione rurale di Puglia e non solo, deriva dalla originaria costruzione, probabilmente cinquecentesca, con quattro torri circolari, collegate tra loro, con funzione di difesa, destinata ad ospitare la famiglia Acquaviva d’Aragona durante l’esercizio della caccia.
La costruzione fu soprelevata a metà del Seicento, con una struttura che richiama i palazzi veneziani, con le quattro torri originarie abbassate e collegate a balconi angolari: l’originaria struttura difensiva si aprì, con due logge contrapposte, sulla lussureggiante campagna circostante. L’origine degli Acquaviva risale a Rinaldo, signore di Atri, vissuto intorno all’anno Mille, uno dei grandi feudatari dell’Abruzzo Teramano, nel 1479 aggregati alla famiglia reale dei re aragonesi di Napoli, con il privilegio di inquartare il loro stemma e, pertanto, da allora detti Acquaviva d’Aragona: una delle più importanti famiglie del Regno di Napoli.
Con la conquista normanna della Puglia a metà dell’XI sec., la città di Conversano acquisì importanza strategica, infatti dalla sua collina si domina un largo tratto della costa adriatica. In Conversano si stabilì il conte Goffredo con la sua famiglia, istituendo la contea più importante di Puglia, a cui erano aggregate varie altre città, come Brindisi e Nardò.
Con l’estinzione della famiglia di Goffredo, la contea di Conversano fu unita a quella di Loretello, in persona di Roberto de Vassonville e, dopo di lui, ad una lunga serie di feudatari: Roberto da Bari, Ugo Lupino, Berardo Gentile conte di Loreto, Berardo da Celano, Ruggero da Pescina, Andrea da Bari, Filippo Chinard, Adamo Morier, Giovanni Chauderon, Giovanni Lescot, Ugo de Brienne, Gualtieri II de Brienne, Gualtieri VI de Brienne, Isabella de Brienne, Luigi d’Enghien, Giovanni de Luxembourg, Giovanna Sanseverino, Manfredi da Barbiano di Cunio, Giacomo Caldora, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, principe di Taranto. La contea di Conversano divenne feudo degli Acquaviva d’Aragona con il matrimonio (1456) di Giulio Antonio Acquaviva con Caterina, figlia del citato principe di Taranto, della quale costituì la dote.
La contea rimase sotto il dominio della Casata fino al 1806, quando fu abolito il feudalesimo nel Regno di Napoli. Essa comprendeva, oltre a Conversano, Acquaviva [delle Fonti], Alberobello, Bitetto, Bitonto, Casamassima, Gioia [del Colle], Cassano [delle Murge], Noci, Turi, Castellana [Grotte], il villaggio disabitato di Castiglione, Nardò e Palo [del Colle]. Notevoli furono le figure di alcuni duchi e conti di Casa Acquaviva d’Aragona, fra cui il citato Giulio Antonio, valoroso uomo d’armi al servizio degli Aragonesi, che partecipò anche ai fatti di Otranto (1480-1481), rimanendo vittima di un agguato turco. Suo figlio Andrea Matteo, uomo d’armi, ma soprattutto dotto umanista e raffinato bibliofilo, partecipò alla Congiura dei baroni del 1485 contro il re aragonese; si schierò contro gli Spagnoli nel conflitto tra Francia e Spagna fra la fine del Quattrocento e i primi del Cinquecento per il possesso del Regno di Napoli, provocando così l’assedio di Conversano da parte degli stessi Spagnoli.
Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, detto, tardivamente e infondatamente, il “Guercio di Puglia”, fu il più potente feudatario della Puglia del XVII sec., fondatore di Alberobello, noto per la maestria nell’uso delle armi, per il coraggio e per il suo raffinato mecenatismo. A soli 17 anni, a capo di 300 cavalieri, difese Manfredonia dai Turchi (1620).
Pur essendo il principale referente della fazione filofrancese del Regno di Napoli, si schierò a difesa del governo spagnolo nei moti del 1647 e 1648 che, iniziati con la rivolta di Masaniello a Napoli, si propagarono rapidamente, assumendo anche un carattere antifeudale. Alla illuminata committenza di Giangirolamo II si devono, fra l’altro, le 10 tele raffiguranti episodi de La Gerusalemme Liberata, del pittore napoletano Paolo Finoglio, che egli chiamò a corte intorno al 1620, nonché la fastosa chiesa di San Cosmo, ricca di tele dello stesso pittore, di stucchi e affreschi di suoi allievi. A lui e a sua moglie Isabella Filomarino di Roccadaspide, si deve l’ampliamento del “castello di Marchione”, come si ricava dallo stemma dipinto sul soffitto.
Con Giangirolamo II, alla contea di Conversano fu aggregato il ducato di Nardò, pervenutogli per eredità materna e, per parte di Isabella, il feudo di Palo [del Colle], acquistato da suo padre Tommaso Filomarino. Dopo la morte di Giangirolamo II e con il trasferimento della famiglia a Napoli, la contea di Conversano si avviò verso una lenta decadenza. Nel XIX sec. il castello divenne masseria. L’edificio fu acquisito dal cavaliere Andrea Acquaviva d’Aragona, il quale lo lasciò a suo nipote Francesco, duca di Nardò, padre della principessa Giulia Acquaviva d’Aragona, moglie del principe di Boiano e duca di Monasterace Giustiniano Tomacelli Filomarino. La principessa avviò una paziente opera di restauro.
Tale opera di salvaguardia e valorizzazione fu proseguita con amore, competenza e impegno dal figlio, principe di Boiano e duca di Monasterace don Fabio Tomacelli Filomarino (1920-2003), decorato anche con i titoli di Casa Henriquez e, per parte materna, di quelli di Casa Acquaviva d’Aragona. Uomo di grande e profonda religiosità, sempre attento ai bisogni ed alle sofferenze della gente, autentico testimone di uno straordinario stile di vita, ultimo discendente di Casa Acquaviva d’Aragona.
Al piano superiore dell’edificio, i soffitti, originariamente in legno e dipinti, furono sostituiti nel XIX sec. con volte in muratura, eccezion fatta per il soffitto del salone centrale, dove è raffigurato lo stemma inquartato della Casa Acquaviva d’Aragona (blasonatura: nel 1° e 4°, contrainquartato in palo: a) d’oro a quattro pali di rosso (Aragona); b) fasciato di rosso e d’argento di otto pezzi (Ungheria); d) d’azzurro, seminato di gigli d’oro (Angiò); e) d’argento, alla croce patente d’oro, accantonata da quattro crocette dello stesso (Gerusalemme); nel 2°, partito, 1° di verde, a tre bande di rosso bordate d’argento (Filomarino); 2°, d’azzurro, alla banda d’argento bordata di nero (di Capua); nel 3°, d’oro, al leone rampante d’azzurro (Acquaviva). Al punto d’onore, Acquaviva.).
Nel salone si osservano, sulla parete sinistra, due alberi genealogici dipinti su tela: il primo è della Casa Acquaviva d’Aragona, il secondo è quello della Casa Enriquez (Casa reale di Castiglia, di cui un ramo si è estinto nella Casa Filomarino), principi di Cutrofiano e Squinzano, marchesi di Salice [Salentino] e di Campi [Salentina]; sulla parete opposta un dipinto ad olio raffigura, forse, Giangirolamo II. Sulle pareti più in basso, dei “medaglioni” dipinti ad olio su rame, raffigurano vari duchi di Casa Acquaviva, un ritratto del cardinale Troiano Acquaviva d’Aragona, ramo d’Atri, oltre a due tondi raffiguranti Ascanio e Scipione Filomarino, i ritratti del re Filippo V di Spagna e di sua moglie Elisabetta Farnese, un probabile ritratto di mons. Francesco Acquaviva d’Aragona e uno del duca Francesco Tomacelli e stampe raffiguranti alcuni cardinali appartenenti alla Casata.
In una stanza attigua, un quadro raffigura la contessa Isabella Filomarino di Roccadaspide, moglie di Giangirolamo II, che resse la contea durante le assenze del consorte e alla cui pia volontà si deve la costruzione della chiesa del Carmine a Conversano (1652). Vi sono qui anche riproduzioni di opere di Tiziano Vecellio e di Paris Bordon, raffiguranti rispettivamente Gianfrancesco II e Giulio Antonio II Acquaviva d’Aragona, nonché immagini del castello di Conversano e della camera con alcova di Giangirolamo II e di Isabella, decorata con stucchi e affreschi, prima opera da loro commissionata a Paolo Finoglio.